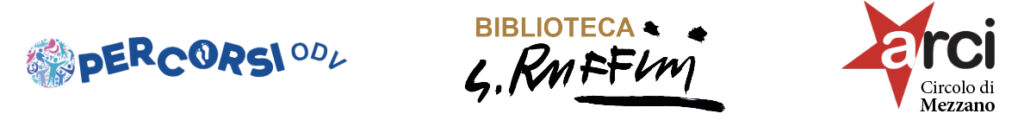I luoghi e la storia
Lotta e Resistenza
“Nei mesi della guerra, nell’estate del ‘44, un suo zio di soli 37 anni, Pietro Lucci, verrà fucilato dai tedeschi per una rappresaglia il 26 agosto insieme ad altri cinque incolpevoli ostaggi poco lontano da casa, alla Camerlona ai bordi della Statale Adriatica. Perciò nei primi anni del dopoguerra, al momento di tracciare una sua personale ricerca d’autore, Ruffini osserva sì le avanguardie cittadine del tempo e il panorama figurativo europeo, ma come molti suoi coetanei romagnoli ritiene prioritari e irrinunciabili i riferimenti e i valori dell’ambito locale. Tanto più che la famiglia trasferitasi nuovamente a Glorie, aveva finito per abitare al numero 8 della via intitolata proprio allo zio fucilato”.

Eccidio di partigiani, 1955 (Ferrara, Museo del Risorgimento).
Nel 1951 vince a Milano il “Premio Diomira” come miglior giovane disegnatore italiano, ma fino agli ultimi giorni si ostinerà a descrivere il repertorio delle sue opere, non attraverso comode fotografie, ma con rapidi bozzetti a penna che riproducono sui fogli di piccoli album le forme identificative dei suoi quadri, anche dei più complessi.
Il primo decennio del dopoguerra è il tempo dei concorsi e dei premi di pittura a cui devono partecipare quanti, cresciuti fuori dalle accademie, devono farsi conoscere dai critici di partito, per poi essere recensiti e pubblicati nelle rubriche della stampa militante o sulle pagine della rivista Realismo.
A Bologna nell’autunno 1952, durante il Congresso nazionale della Federbraccianti, si tiene di sera nello stesso salone un incontro fra pittori e delegati sindacali. Dalla platea si alza un capolega sardo e grida: “Dovete essere vicini alle nostre esigenze, al nostro bisogno di arte!”
e Ruffini ascolta, sia l’appello degli operai che del critico Mario De Micheli.
Che per quei pittori si trattasse della ricerca di un linguaggio, di una poetica nazional-popolare o meno, oggi poco importa; è comunque un fatto significativo che il nostro artista anche negli anni a seguire non abbia accolto l’invito suadente di amici come Mattia Moreni o Renato Guttuso a trasferirsi nelle capitali dell’arte contemporanea e partecipare ai movimenti d’avanguardia, quanto piuttosto abbia cercato, a partire dalle sue origini romagnole, di affinare una propria espressività all’interno di una precisa condizione storica.
Anche dal suo ristretto ambito personale, per Ruffini si potevano contemplare i drammi più recenti e trasfigurarli in una dimensione assoluta, senza cadere nelle paludi della retorica di circostanza.
In questo senso opere personalissime, che connotano quel suo primo periodo, sono un interno domestico visto dalla finestra, del 1952 intitolato I poveri, capace di condensare tutta la drammaticità di un padre senza lavoro, che non può offrire nulla al piccolo figlio con le braccia protese; tra le mani aperte del bambino e gli occhi chiusi del padre si consuma una delle più toccanti rappresentazioni di tensione e di impotenza della pittura realista italiana. In quel diffuso panorama rurale l’artista si raffina cercando continuamente delle forme primarie con le quali comporre i soggetti prediletti. I braccianti, i renaioli e le donne di quell’ambiente, ritratti al lavoro o durante una sosta, fra attrezzi del mestiere, fiaschi e sporte impagliate della “sua Villanova”, sono nobili testimoni di un epos e di una moralità in cui l’artista si riconosce e si ispira.
Un’opera pregevole di questa stagione datata 1953-54, come le Due braccianti che riposano, di ritorno dalla XXVII
Biennale di Venezia fu acquistato nel 1955 dal Comune di Alfonsine per abbellire la Sala Consiliare del municipio appena ricostruito, proprio come nobile rappresentazione della comunità.
I quadri a olio più noti giungono a compimento solo dopo infiniti bozzetti di studio, sulle mani incrociate, su pochi oggetti evocativi, sulle posture antiche, che sono il linguaggio corporeo più espressivo della gente piegata dalla fatica.
Il vissuto familiare lo rende esperto soprattutto nell’osservazione delle pose femminili: che siano le braccianti dai fianchi larghi o le donne disposte in fila per la veglia al defunto, ci appaiono sempre per la forza delle loro figure, per la massa degli abiti scuri o dei fazzoletti in testa che coprono parte del volto.
È questa evidenza del dettaglio che rende riconoscibili i personaggi raffigurati: non sono profili generici i suoi, bensì quelli usciti dal suo mondo, con il fazzoletto rosso dei contadini, i grembiuli sopra gli abiti femminili e l’ombrello che ripara dal sole e dalla pioggia. Si avverte in queste sue composizioni dedicate al mondo dei vinti quell’accurata scelta di oggetti simbolici che verrà sublimata nella stagione successiva, quella delle icone rurali disposte nei teatrini di memoria, fra lumi a petrolio, legni nodosi e stampe seppiate.
Quelli che Francesco Arcangeli chiamava “i tramandi della provincia”, più che dalla provincia sgorgavano dal suo vissuto personale, come gli interruttori di ceramica, il filo elettrico intrecciato o le carte romagnole con cui avrà giocato a lungo con la nonna nei pomeriggi trascorsi ad aspettare il ritorno della madre.
C’è poi un altro nucleo tematico di opere, destinate anch’esse ad evolvere in pietosa religiosità, e sono le scene dei massacri di inermi e delle fucilazioni del tempo di guerra. Ruffini li aveva conosciuti; già ventenne, ne era stato colpito in famiglia e ne conservava il lutto. Ora riportava sulla tela e dilatava quel dramma personale a categoria assoluta. Nella famosa Veglia per il bracciante ucciso, e in altri bozzetti simili in cui al bracciante si sostituisce il partigiano, l’artista sovrapponeva quel dramma ai coevi episodi di cronaca che negli anni Cinquanta videro i reparti della Celere sparare sui braccianti e caricare i dimostranti disarmati. È stato scritto che tali episodi non appartenevano al suo raggio d’osservazione, quanto piuttosto ad un generico afflato meridionalista di stampo guttusiano, ma la vicenda familiare pesava ancora e nella primavera del 1949 erano caduti per mano della polizia uomini e donne a Molinella, a S. Giovanni in Persiceto e a Comacchio. L’anno 1950 si era aperto a gennaio con i sei operai di Modena colpiti a morte durante una manifestazione in difesa del lavoro.
La guerra era finita da poco, ma i poveri continuavano a soffrire l’arroganza del potere.