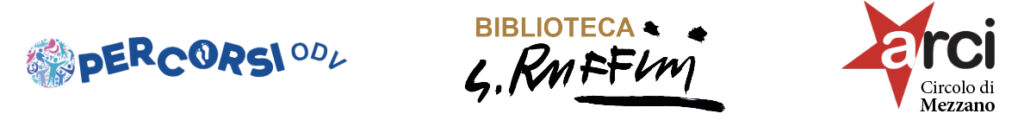Città/campagna (1960-1970)
Il disegno della campagna viene scosso dall’urbanizzazione, il pittore si trasferisce in città. Attorno al 1960 il collegamento che lo teneva unito al luogo d’origine si tronca di netto. Lo spazio figurativo del pittore conosce per la prima volta l’apertura su un presente la cui forma non è già predeterminata, ma diventa spazio aperto a differenti potenzialità compresenti. E’ l’effetto della nascita di una individualità che si riconosce in possesso di una libertà prima impensabile, ma anche di solitudine e disperazione sconosciute. Questo è il momento di equilibrio fra passato contadino e presente urbano.
Gli anni del secondo dopoguerra, tra mille illusioni e sostanziali perdite, sono quelli di Ruffini. Dal confronto con questa terra desolata, forse, trova prima motivazione la sua incessante, tormentata e inesausta ricerca che si concretizza in cicli tematici ed espressivi, spesso autonomi per l’intonazione (dall’impegno civile al ricorso a simbologie religiose), i mezzi e i riferimenti adottati.
Da qui sorge anche quella sua pervadente vena malinconica che non è altro - sotto l’onnicomprensivo segno della scomparsa di un mondo, di una cultura e di una terra - che il frutto di una, per lui, decisiva percezione: la “scomparsa della Romagna” è la fine di tutte le terre, una fine simbolo di tutte le fini, di ogni tempo e di ogni luogo.
Anche ogni ciclo pittorico di Ruffini ha una fine ma, a fianco di questi capitoli interrotti, cresce e si sviluppa negli anni un libro segreto, una sorta di diario personale, dove, al riparo dalle sollecitazioni della critica militante, dalle pressioni ideologiche e dal contingente, Ruffini riporta anno per anno, senza soluzione di continuità, i suoi tanti movimenti di pensiero nella forma più semplice e tradizionale: la natura morta.
Al Catalogo ragionato, suddiviso in 4 capitoli, si affianca il Catalogo generale, che contempla pressoché tutte le opere di Giulio Ruffini (suddivise per temi ordinate in ordine cronologico).